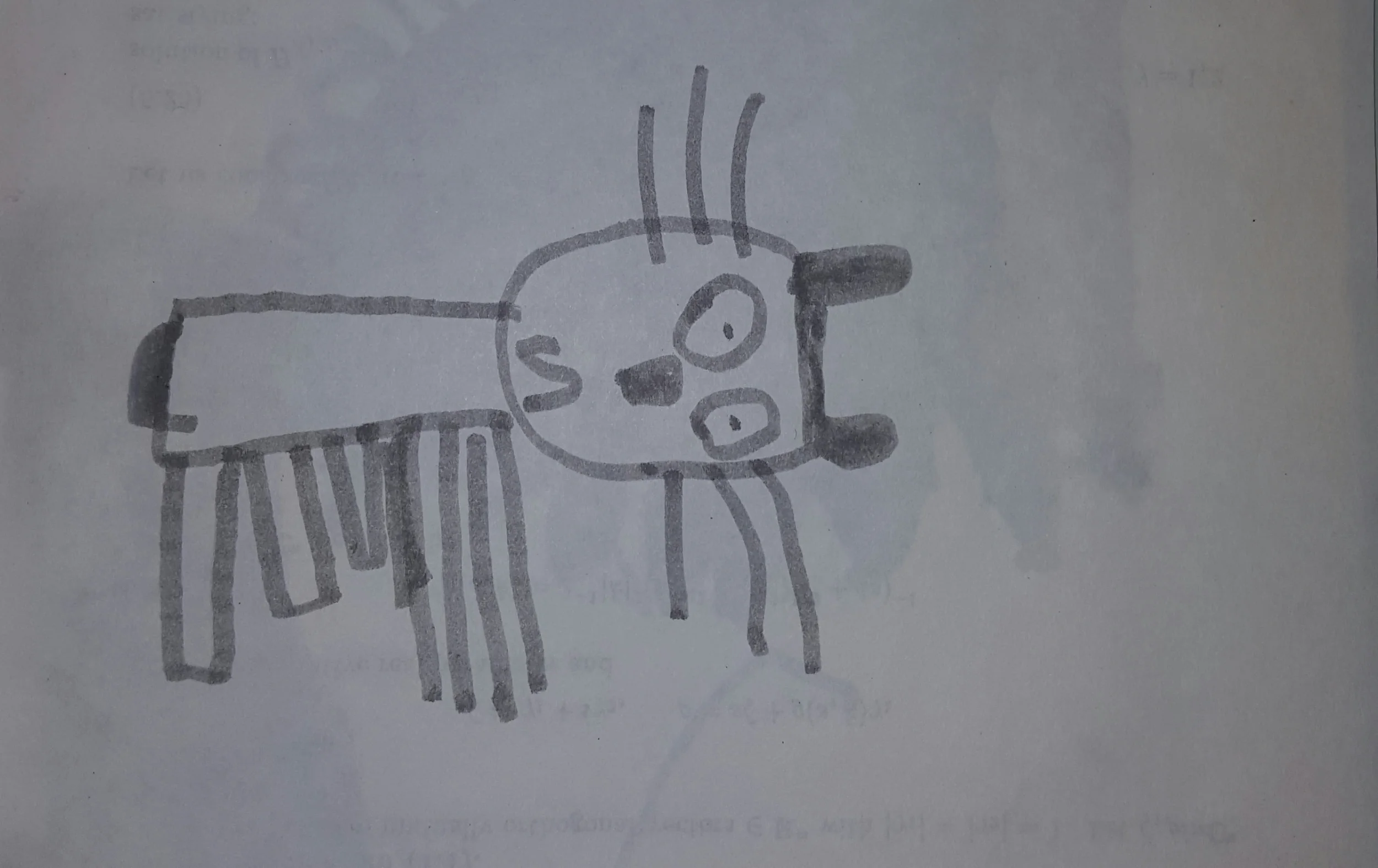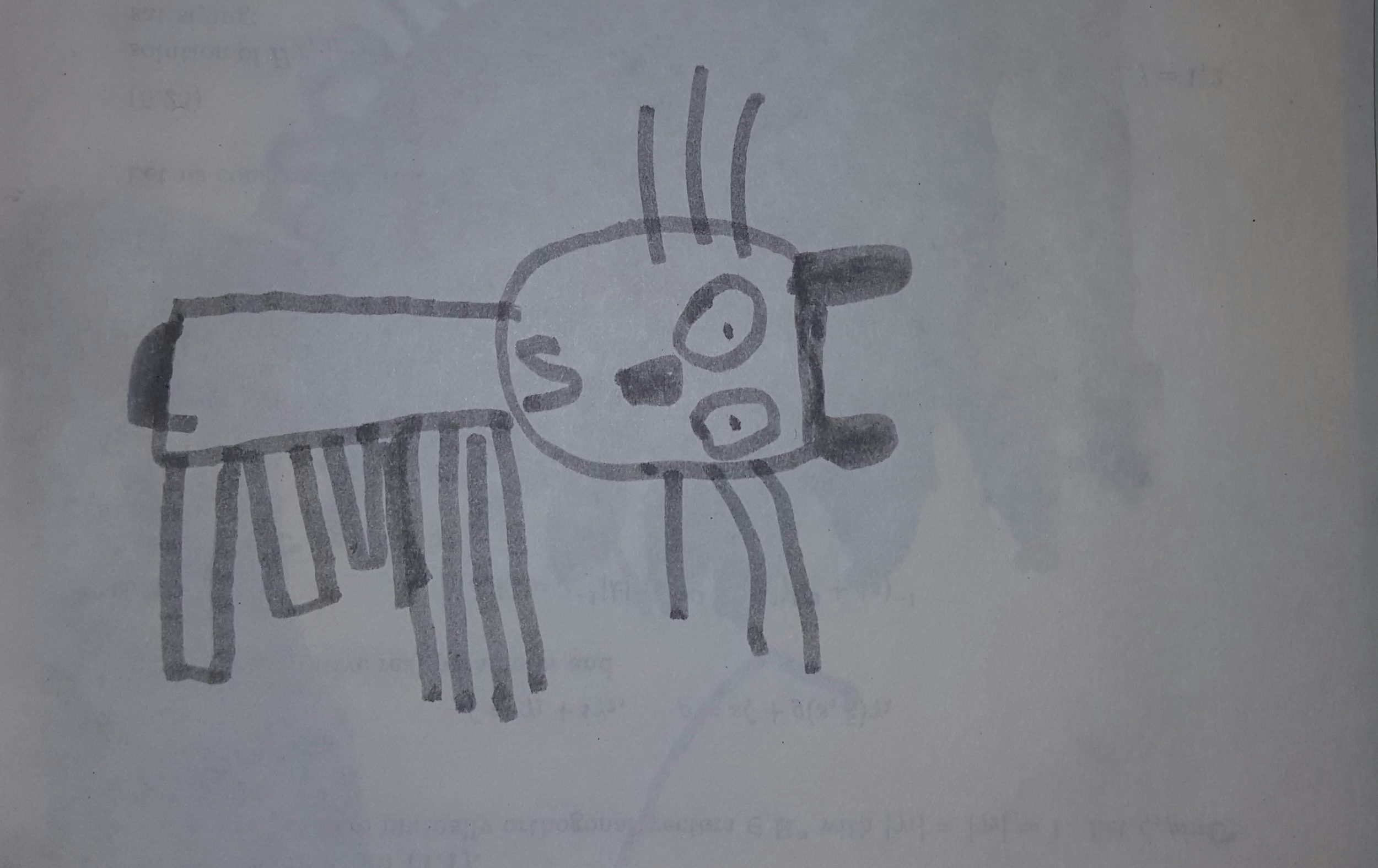Circa tre anni fa la vita della nostra famiglia cambiò radicalmente.
Quella mattina di fine settembre, era venerdì, L. si svegliò dopo una notte agitata; aveva febbre a 38° e per circa trenta secondi accusò delle lievi scosse nella mano sinistra, dopo aver riferito di sentire un “filo” fastidioso nel braccio. Nelle due ore successive all’evento, quella manina restò priva di sensibilità e di capacità prensile. Mi misi subito in contatto con il pediatra, che visitò L., mi parve con attenzione, concluse che poteva essersi trattato di convulsioni febbrili e, per precauzione, ci inviò in un ospedale periferico per fare un accertamento neurologico. Io mi affidai (ahinoi, ciecamente!) alle sue indicazioni e mi recai presso l’ospedaletto, assolutamente ignara della gravità di ciò che stava accadendo. Lì fummo accolti dal personale del pronto soccorso, quindi inviati in pediatria, dove il bambino fu sottoposto ad una prima visita, poi fu eseguito un encefalogramma. Conclusero che era “tutto regolare”, ma, per precauzione, ci ricoverarono “in osservazione”. E, da quel momento, per due lunghi giorni e tre interminabili notti osservarono, osservarono e basta, finché non ebbimo la sensazione che non avessero il controllo della situazione. Nessuno rispondeva in modo circostanziato alle nostre domande, tutti sembravano principalmente preoccupati di sedare le mie ansie materne, di evitarne l’insorgenza. Qualcuno parlò a denti stretti di “epilessia come quesito dignostico”, ma secondo loro era compito del nostro pediatra darci le informazioni dettagliate del caso, poi fecero una tac, per escludere la presenza di una “massa” nel cervello, infine una rachicentesi, ma dal solo aspetto del liquor capirono che non si trattava di un “problema batterico”. Solo oggi mi rendo conto dell’immensa gravità di ciò che ricercarono e che, fortunatamente, esclusero: epilessia, tumore, meningite. Allora, incosciente e inesperta, incredula e naif, neanche lontanamente riuscii a mettere a fuoco queste tre terribili parole.
Durante la terza notte fummo trasferiti in ambulanza a sirene spiegate in un (vero) ospedale pediatrico, dove L. fu accolto in pronto soccorso e immediatamente ricoverato in terapia intensiva, sedato in coma farmacologico e affidato alle cure di una (vera) neurologa, che gli salvò la vita. Io e mio marito seguimmo la barella nel lungo e asettico corridoio tra il pronto soccorso e la terapia intensiva; ricordo che chiesi, incredula: “Perché corrono?!”. Ora so perché correvano, ma l’ho capito troppo tardi. Poco dopo, le porte grigie della terapia intensiva si chiusero, sbattendo forte, sui nostri nasi. Ci accomodammo su due rigide e strette poltroncine,collocate di fronte alla porta del bagno pubblico, in attesa della sentenza. Circa tre ore dopo ricomparve il medico del pronto soccorso, accompagnato dalla neurologa. Ci spiegarono che erano in attesa di formulare una diagnosi scientificamente provata, ma che l’ipotesi più probabile era che L. fosse affetto da encefalite, che poteva essere di origine virale o genetica, che le crisi convulsive erano state finalmente sedate e che sarebbe stato sottoposto il prima possibile a risonanza magnetica, per accertare l’entità del probabile danno cerebrale. Tante parole dure, inequivocabili, questa volta non mormorate a denti stretti, ma urlate al vento, senza alcun riguardo per le mie ansie materne. Ricordo una nuvola nebbiosa di pensieri galleggianti nella mia testa, con solo due punti fermi e nitidi: le parole “virale” e “genetica”. Portavo in grembo la nostra secondogenita; proprio in quei giorni ero alla fine del terzo trimestre. Non riuscii a dire nulla, se non a chiedere, in modo confuso, se tutto questo poteva rappresentare un rischio per la mia gravidanza. Fui invitata a mettermi in contatto col mio ginecologo, “Io sono qui per prendermi cura del vostro primo figlio; tutto il resto non mi riguarda”. Stop. Fummo invitati ad andare a casa “a riposare”.
Nei giorni successivi pendolammo tra casa nostra e la terapia intensiva, in un turbine di sensazioni ed emozioni terribili: shock, costernazione, rabbia, incredulità, confusione, terrore, orrore, sfinimento… Ogni giorno ricevevamo una cattiva notizia: il tracciato dell’encefalogramma non si riorganizzava, il bambino doveva essere aiutato con la respirazione artificiale, la collocazione e il numero delle lesioni rilevate non facevano sperare nulla di buono. Iniziarono a prepararci al fatto che il nostro bambino si sarebbe risvegliato in condizioni molto diverse da come noi lo conoscevamo: avrebbe potuto essere affetto da dislalia, emiparesi, forse perfino da uno stato vegetativo, con tutta probabilità avrebbe acquisito una epilessia grave, forse non sarebbe stato neppure in grado di nutrirsi autonomamente. Finché, il sesto giorno, L. fu risvegliato e, con un solo occhio aperto, mi chiese del “gelato, tanto, subito, al melone”. Queste poche parole, ma nitide, chiara espressione di un desiderio consapevole, di un appetito, riaccesero all’improvviso le nostre provate speranze. Nella via dell’ospedale c’è una meravigliosa gelateria artigianale, dove fu immediatamente procurata una immensa coppa di gelato al melone.
Da quel giorno si iniziò a programmare il percorso riabilitativo, che durò sei faticosi mesi, densi di terapie stancanti e intensive, ma estremamente produttive. Non mancarono le ansie e le brutte sorprese: scoprimmo, infatti, che l’encefalite aveva provocato uno stroke emorragico, comparvero un paio di crisi epilettiche, fummo costretti ad accettare l’impossibilità di formulare una diagnosi e a convivere con l’incertezza del futuro.
Ma la nostra storia ebbe un bel finale: L. oggi è un bambino sereno, cognitivamente normale, affetto da una emiparesi alla mano sinistra, costantemente sottoposto a visite di controllo, terapie riabilitative e stimolanti, primo e quasi unico oggetto delle nostre attenzioni, cure, premure, ansie, preoccupazioni, prevenzioni, affetto, amore incondizionato… La nostra seconda bimba nacque pochi giorni dopo la fine del primo periodo di riabilitazione intensiva. E oggi aspettiamo l’arrivo della nostra terza bimba.
Tutto questo per dire che la forza della vita è incredibile e che i figli sono il senso più bello della nostra unione. Per questo ci uniamo, resilienti, al grido di battaglia: Lotta e Sorridi!